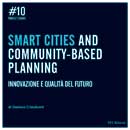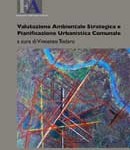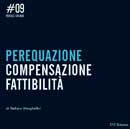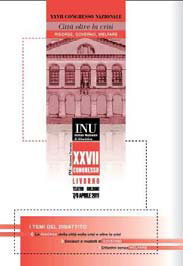Dopo i disastri (di Lodi) le promesse ferroviarie
16/02/2020
Di Francesco Domenico Moccia, segretario nazionale Inu
Quasi assieme all’incidente di Ospedaletto Lodigiano Legambiente lancia l’annuale rapporto Pendolaria dove l’alta velocità trova un riconoscimento di sviluppo eccezionale. Sulle Frecce di Trenitalia e Italo si spostano quotidianamente 170.000 passeggeri. Sono stati 350 milioni in dieci anni con una flotta di treni che è passata da 74 a 144. L’incremento su Trenitalia è stato del 517% dei passeggeri che passano dai 6,5 milioni del 2008 ai 40 milioni del 2018.
Per i trasporti regionali e metropolitani si cerca di cogliere i segnali positivi capaci di dare una base concreta alle prospettive di un ruolo importante nella transizione verso la mobilità sostenibile. Si spera di risalire la china della crisi degli anni scorsi sottolineando i dati che segnano una svolta comunque di crescita del numero dei pendolari che usano il treno. Nel 2018 i passeggeri quotidiani dei treni regionali è aumentato di 45.000, 1,6% in più rispetto al 2017, mentre quelli dei treni metropolitani di 65.00, 2,4% in più. La crescita in cinque anni è stata dell’11,7%. Qui i divari regionali sono grandi: in Lombardia prendono il treno 802.000 persone al giorno con un incremento del 43,4% rispetto al 2009 mentre in Campania dal 2011 al 2019 si ha una riduzione del 43,7% passando da 467.000 a 262.855.
L’interpretazione dei ricercatori è che poiché dove si registrano investimenti nel miglioramento del servizio là si ottiene un incremento degli utenti, allora questo significa che esiste effettivamente la domanda per questa modalità di trasporto. La preferenza è stata verificata anche con interviste dove è stato individuato quali fattori rendono più gradevole e desiderabile il viaggio. Dalla lettura del rapporto si possono fissare alcune linee di una politica per il trasporto di massa. Tra di esse voglio sottolineare quelle che vengono indicate come delle carenze che hanno anche una portata urbanistica e costituiscono leve strategiche per realizzare un vero cambiamento.
La domanda di trasporto maggiore si concentra nelle aree metropolitane ma qui abbiamo allo stesso tempo la massima carenza del trasporto su ferro. A fronte di ciò, l’Italia ha un tasso di motorizzazione tra i più alti al mondo: 70,7 veicoli ogni 100 abitanti. Il tasso di Madrid è di 32, Berlino 35, Londra 36. Ad essi è correlato la percentuale di spostamenti quotidiani su trasporto pubblico rispettivamente del 39%, 44%, 52,6%. Milano raggiunge il massimo con il 21%. Lo sviluppo totale delle metropolitane italiane raggiunge i 247,2 Km, ed è inferiore a quello della sola città di Madrid che arriva a 291,5 Km. Campos Venuti inventò negli anni ’90 lo slogan della “cura del ferro” come obiettivo prioritario del piano di Roma a cui stava lavorando. L’idea è stata generalizzata ed è oggetto di attenzione per ogni progetto urbanistico successivo. È entrato nel linguaggio comune e ripreso anche dagli autori di Pendolaria. Resta un compito ancora da attuare e una linea essenziale per la rigenerazione urbana. Sappiamo che costruire nuove linee metropolitane è operare una riorganizzazione delle conurbazioni originariamente sviluppate sul trasporto individuale su gomma e da ricondurre ad un nuovo sistema di accessibilità con relative centralità e sistema di spazi pubblici. Anche quando il rapporto si focalizza sulle stazioni, la cui ristrutturazione è molto apprezzata dagli utenti, in esse vi leggiamo l’interfaccia tra trasporto e città dove il legame con il contesto del semplice edificio è il fattore d’integrazione.
Il legame tra trasporto e rigenerazione lo troviamo anche nella riattualizzazione delle linee tramviarie. Emblematico il caso di Firenze dove la media degli spostamenti sull’asse Firenze Scandicci è di 25.000 al giorno con un tempo di percorrenza di 40 minuti per gli 11,5 km e 26 fermate. Ci sono 500 corse al giorno ogni 4 minuti e 20 secondi. La linea tramviaria è anche un corridoio verde e alimenta, nel nodo di Scandicci, il nuovo centro civico, dove introno alla piazza, sede della fermata del tram, si riunisce il nuovo palazzo comunale, la biblioteca ed altri servizi. Il tram ha una fermata alla stazione di Santa Maria Novella dove il passeggero può proseguire sulle linee regionali o nazionali.
I reciproci benefici di linee di trasporto brevi e lunghe nell’alimentarsi reciprocamente estendono e rendono capillare il trasporto pubblico locale in maniera coerente ed efficiente. Sappiamo che ciò comporta la ristrutturazione degli spazi urbani di comunicazione, il che significa la grande maggioranza dello spazio pubblico. Dedicare apposite corsie ai tram o autobus dà rilevanti contributi all’efficienza del servizio come ridurre lo spazio disponibile alle auto abbatte notevolmente le emissioni gi gas inquinanti e climalteranti.
Oltre la questione del ritardo dei trasporti urbani, il rapporto evidenzia quello degli squilibri regionali che si manifesta nell’arretratezza del Mezzogiorno elencando le opere di cui c’è maggiore ed urgente bisogno. Propone un riorietamento della spesa pubblica dal sostegno al trasporto su gomma all’investimento nelle infrastrutture e miglioramento del servizio di trasporto pubblico con una dettagliata analisi del bilancio dello stato. Presenta un ampia schedatura di buone pratiche da cui si possono apprendere molte cose utili per la pianificazione.
Per molti motivi è una lettura utile per gli urbanisti.